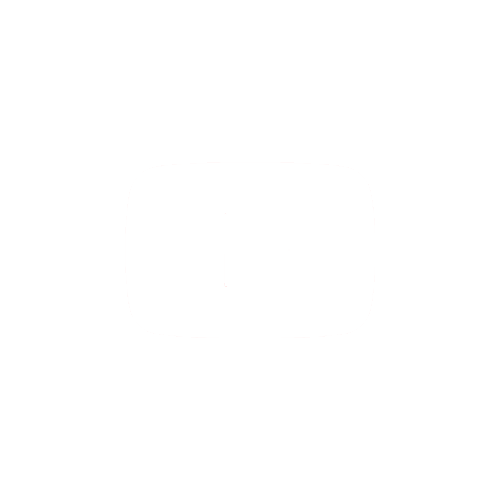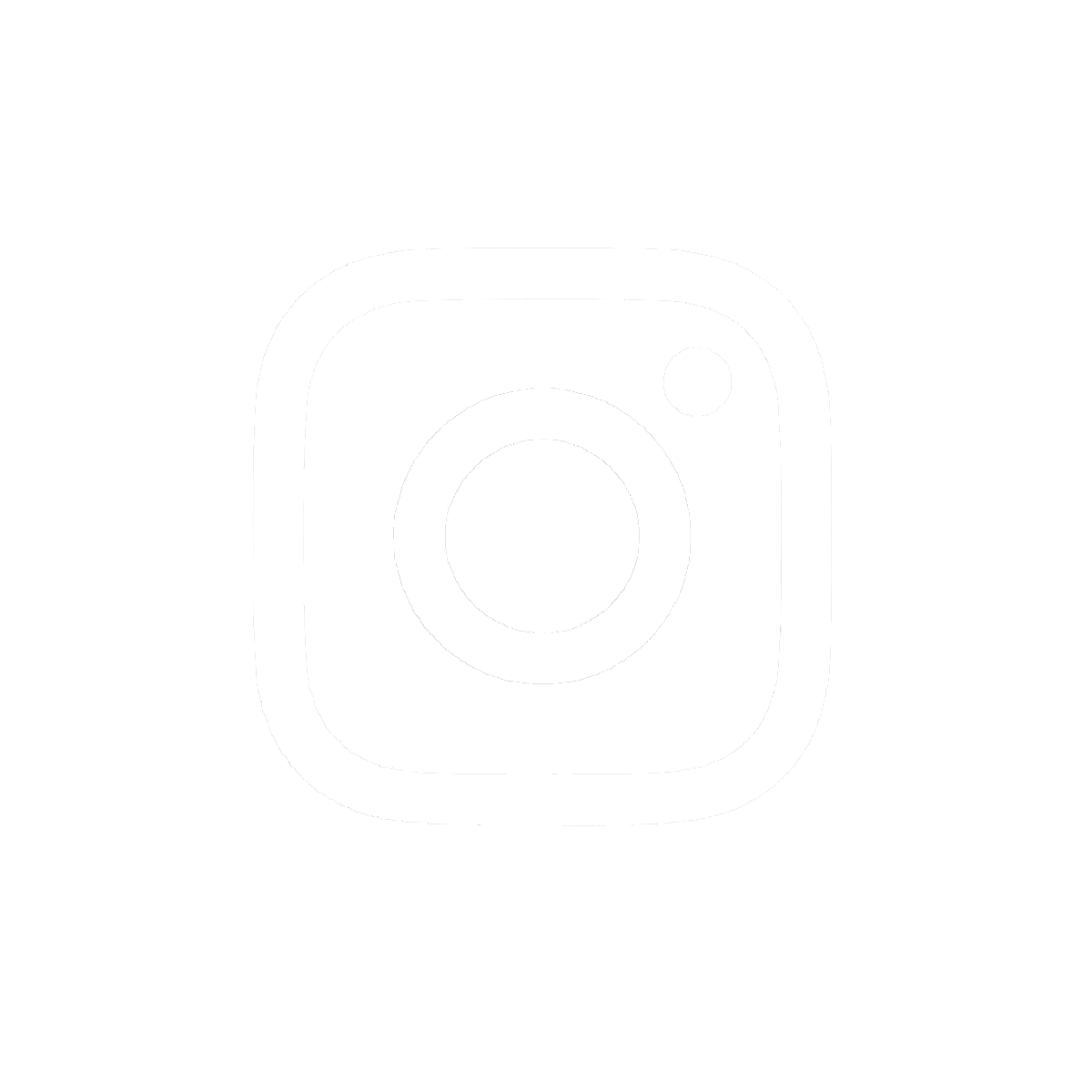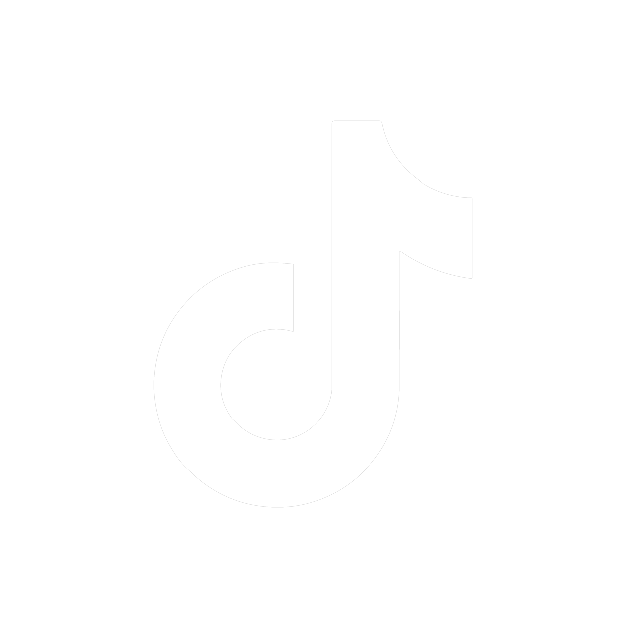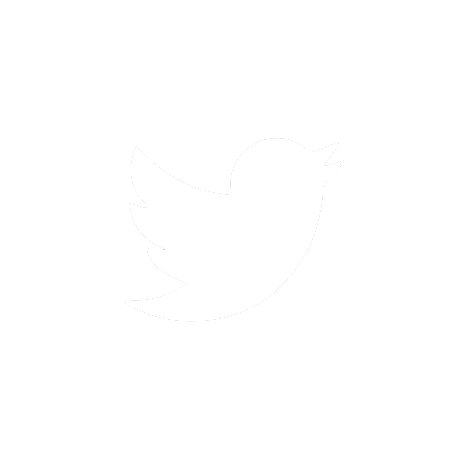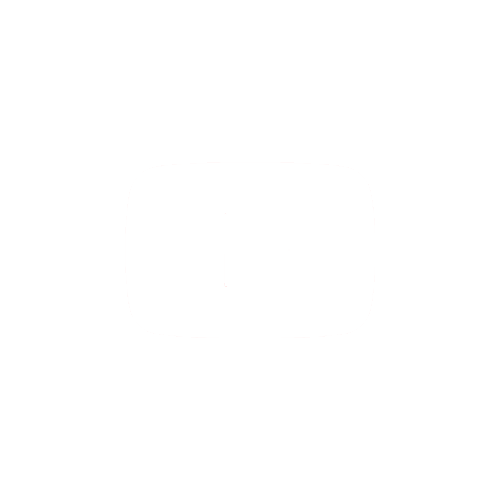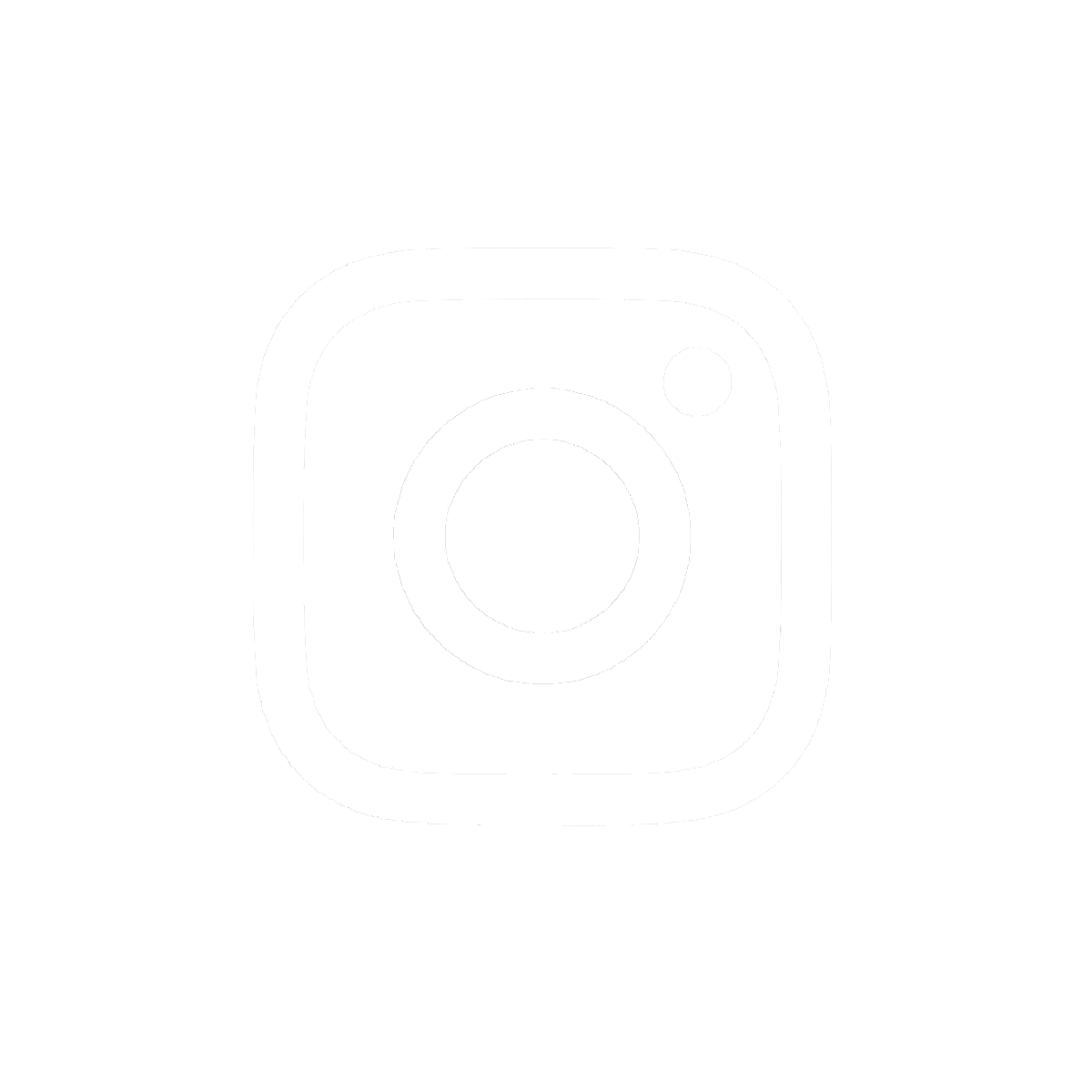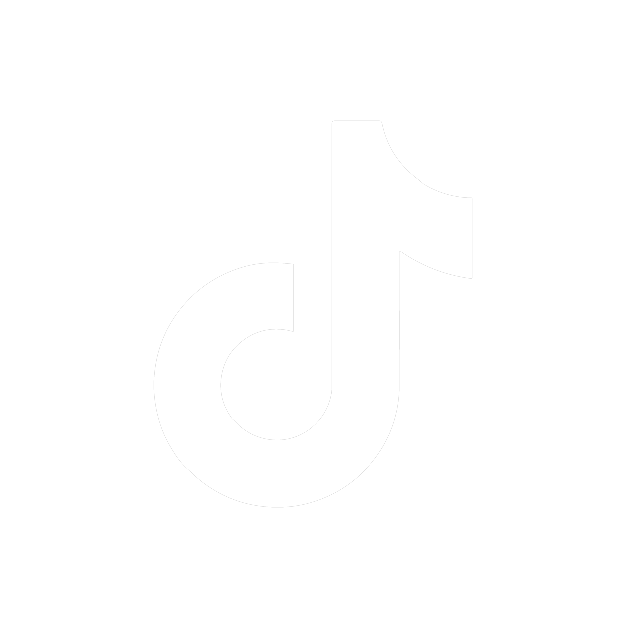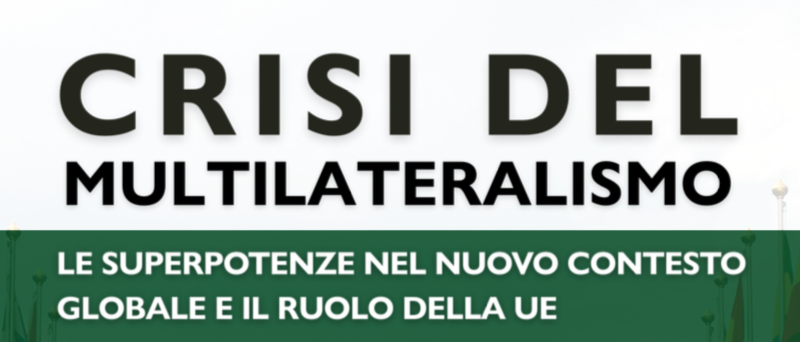Oltre alla criminalizzazione della migrazione, già completata con i precedenti governi e su cui il presente governo non ha aggiunto qualcosa di ulteriore, semplicemente perché non ce n’era bisogno, oltre alla criminalizzazione del dissenso, c’è una specifica criminalizzazione dei più giovani e in particolare degli adolescenti, che vuole prevenire il loro ingresso nel mondo adulto, la loro possibilità di sbagliare e correggersi.
La criminalizzazione usa strategie etichettatorie, ad esempio con l’uso del termine baby gang, oppure del termine bullismo per qualsiasi situazione di devianza. In generale, c’è una leggerezza e una velocità nel condannare qualsiasi comportamento che sembra quasi senza appello.
Smontare il sistema educativo
Di fatto, queste politiche stanno smontando il nostro sistema educativo, piegando il sistema di detenzione già in crisi, che non è pronto ad accogliere un numero così alto di giovani e giovanissimi. L’autoritarismo arriva per gradi, ogni giorno ci toglie qualcosa, una libertà, un diritto, una garanzia ed ogni volta pensiamo che interesserà qualcun altro. Invece riguarda proprio i nostri figli.
Il processo ha alcuni passaggi fondamentali. Il primo è il Decreto Caivano: gli obiettivi apparenti sono la prevenzione dell’abbandono scolastico (rendendo penale la mancanza di intervento della famiglia con reclusione fino a due anni), il contrasto alla criminalità giovanile e alle baby gang. Si parte con il daspo urbano dei soggetti che abbiano compiuto i 14 anni di età, si abbassa a 12 anni l’età per l’ammonimento. In generale gli effetti negativi sulle situazioni veramente complesse sono stati segnalati da tutta la società civile che vi opera, ma quello che interessa è agire in modo autoritario in qualsiasi contesto, anche laddove magari le criticità sono diverse, per “dare un messaggio”.
Il monitoraggio di Antigone
Gli effetti di queste misure sono stati già cartografati da associazione Antigone con un picco di 1143 ingressi di minori nel sistema a fronte dei 992 nel 2014. Scrive sempre Antigone: “Continuando con questi ritmi si rischia di perdere quella specificità positiva del sistema della giustizia penale minorile nel nostro paese che lo aveva reso un modello per l’intera Europa, ovvero la sua capacità di rendere residuale la risposta carceraria puntando piuttosto su un approccio di tipo educativo codificato nel codice di procedura penale minorile del 1988”.
Un altro aspetto certificato dal monitoraggio è che la detenzione non è correlata alla gravità della colpa riconosciuta, ma appare molto più correlata alla “maggiore facilità a individuare percorsi alternativi per coloro che a monte sono già
maggiormente garantiti”. In poche parole, andare in galera o meno dipende da quanto sei socialmente inserito, non dal tuo reato. Un minore straniero per un furto è più facile che sia detenuto, di uno italiano con una famiglia legata al territorio per reati contro la persona.
Un altro aspetto registrato, è l’aumentare delle colpe ascritte con l’ingresso del sistema: spesso entrano con unico reato ascritto, ma poi ne collezionano altri, proprio perché l’aspetto riabilitativo non è al centro del percorso.
Media e clickbaiting
La politica mediatica, che lavora sulla rabbia e frustrazione di molti e che raccoglie molti click, insiste sull’aumento dei reati. È proprio vero? “Nel 2023 i ragazzi denunciati e/o arrestati sono diminuiti del 4,15% rispetto al medesimo dato raccolto nel 2022, permanendo ad un livello che già in passato era stato registrato, senza che questo avesse portato a stravolgere il sistema della giustizia minorile creando una situazione di malessere generalizzato”. La situazione a febbraio del 2025 è ormai esplosiva nelle carceri italiane, con 16.000 detenuti in più rispetto ai posti disponibili e una situazione di affollamento anche nelle strutture minori che non si era mai visto prima.
In questo processo sono state coinvolte anche le scuole, che si trovano a dover segnalare (cosa che già facevano, ma in modo molto più oculato) i casi di assenza sospetti degli alunni soggetti all’obbligo. Vista la penalizzazione dell’evasione scolastica, nessun dirigente si prende la responsabilità di non segnalare, perché magari sa che il ragazzo è in ritiro sociale, ha particolari problemi ecc. Nel dubbio si segnala tutto, con il rischio che poi le vere situazioni sfuggono, anche perché i Comuni non riescono a gestire la mole di richiesta di verifica.
Scuola, da educazione a delazione
Le scuole vengono trasformate in questo processo da istituto educativo e formativo a punto di segnalazione alle forze dell’ordine e al potere giudiziario anche in virtù della L. 70 del maggio 2024, la legge sul bullismo. Di fatto anche in questo caso, si abbassa notevolmente l’età dei minori da segnalare portandola a 12 anni, si toglie la discrezionalità educativa di valutare situazione per situazione l’entità dei fatti, si deroga dall’intervento educativo risolutivo e riparatore, inserendo l’obbligo di procedere a segnalazione alla Procura dei minori che determina il percorso anche educativo. Questo obbligo ha portato ovviamente ad una congestione di segnalazioni che portano le procure ad una valutazione difficoltosa dei
singoli casi, oltre al fatto che si esautora la scuola dal suo compito.
Intorno il clima è incattivito e vorace di notizie che confermino questa criminalizzazione. Trovare i colpevoli, punire, punire senza appello, sono le richieste che si susseguono con più forza nel dibattito pubblico. Per rendere omogeneo l’intervento di etichettatura, ecco anche il voto di comportamento: eliminato nel 1945, fu reintrodotto nel 1956. Nel 1977 scomparve di nuovo dalla scuola elementare e media sostituito da una valutazione globale. La Gelmini nel 2005 reintroduce il voto nella Scuola Secondaria con indicazione di voto minimo 6 con possibilità in caso contrario di non ammissione alla classe successiva a prescindere dalle valutazioni nelle altre materie: è la prima volta nella storia della Repubblica.
Un principio ideologico
Tuttavia non si sono registrati in quegli anni episodi gravi, anzi il numero di reati o trasgressioni relativi allo spazio scolastico sono diventati residuali rispetto a quelli degli anni ‘70 per fare un esempio. Si voleva invece stabilire un principio ideologico, promuovere un’idea di scuola come luogo di ordine e disciplina, che conforma. Questa idea non è stata messa in discussione dai governi di centro sinistra successivi, infatti il voto di comportamento è rimasto immutato da allora. Nel 2024 con il governo Meloni viene reintrodotto il voto di comportamento anche alle medie, con la stessa funzione delle Superiori: nelle Scuole superiori, nel caso di voto pari a 6, si avrà un debito formativo e si dovrà sostenere un elaborato di educazione civica, quindi si cambia addirittura la taratura della sufficienza, visto che nelle altre materie se si ha 6 non si deve fare nessun recupero del debito.
Aggiungo che il voto in condotta diventa determinante per gli studenti delle Superiori in quanto il punteggio più alto nelle materie di studio potrà essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi. Chiaro
che se per caso hai partecipato all’occupazione della scuola, difficilmente otterrai un nove in condotta e anche se hai 10 nelle materie, non potrai avere il massimo dei crediti. Proprio un principio meritocratico.
Buoni consigli, di classe
Chi ha assistito alla discussione in un consiglio di classe sull’attribuzione di questo voto sa quanto sia difficile avere una visione univoca sull’esito dello stesso: ci sono docenti che vorrebbero mettere 7 perché gli alunni sussurrano mentre spiegano e altri che darebbero 9 perché ha buoni esiti scolastici, magari senza nessun contributo civico. Si entra nella logica della morale e non dell’apprendimento o dell’educazione, e quindi ciascuno applica la sua. Vero è che finora neanche nel Regio decreto del 1923 si era arrivati a tanto.
Intanto le etichette si sprecano, ma qual è la realtà? Secondo Transcrime è difficile stabilire i contorni di questo fenomeno usando questo termine, infatti in tutto il rapporto non parla mai di «baby gang» ma al massimo di «gang giovanili». Nello stesso report, che è realizzato da un team interministeriale, Gemma Tuccillo Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità dichiara: “La tipologia prevalente dei gruppi di minori che agiscono atti violenti o illegali si caratterizza principalmente per una scarsa strutturazione interna, per un numero esiguo di componenti e per la connotazione di ‘fluidità’ del gruppo stesso.
Non di rado, l’azione deviante è frutto di un agito immediato senza alcuna pregressa organizzazione o definizione”, dice inoltre che il termine più corretto per definire questi fenomeni è “disagio giovanile”, proprio quello che pare non essere a cuore in questo momento alla legislazione in atto.
di Rachele Nahoum
Volete essere informati delle azioni di DiEM25? Registratevi qui!