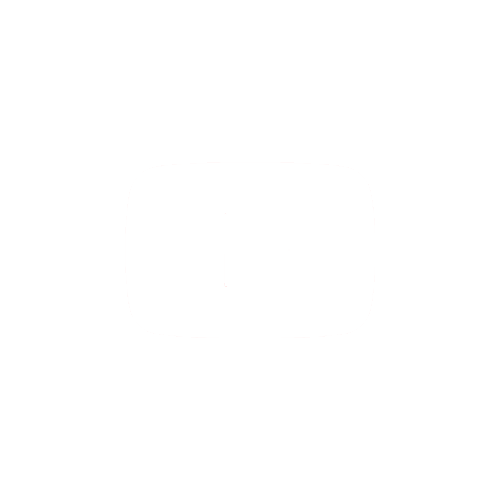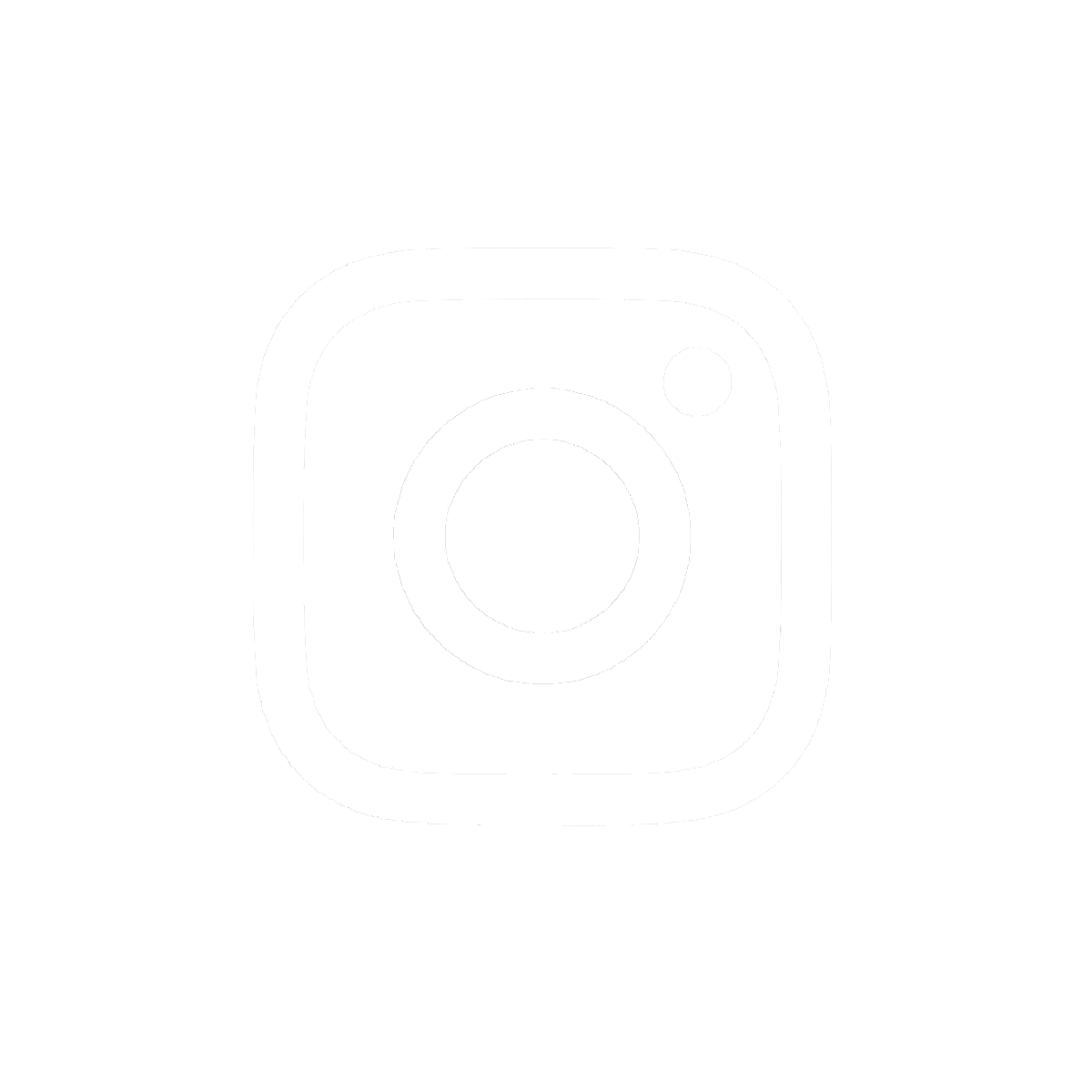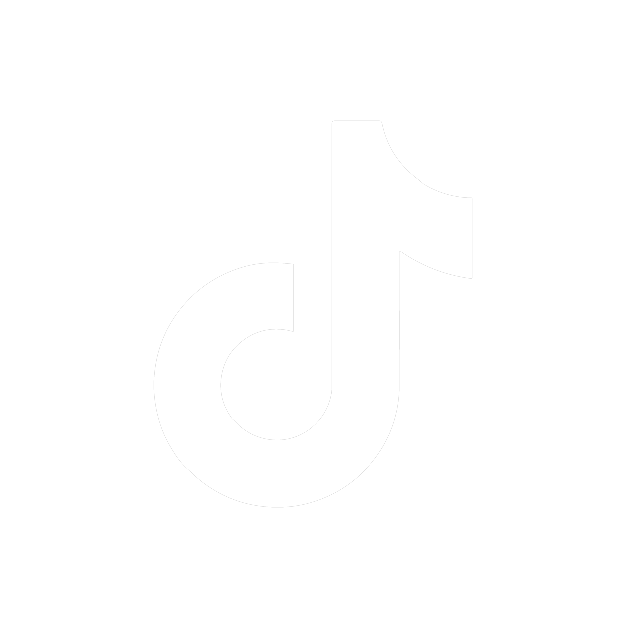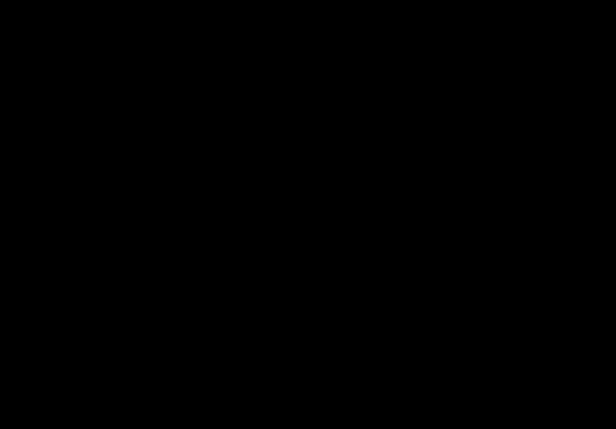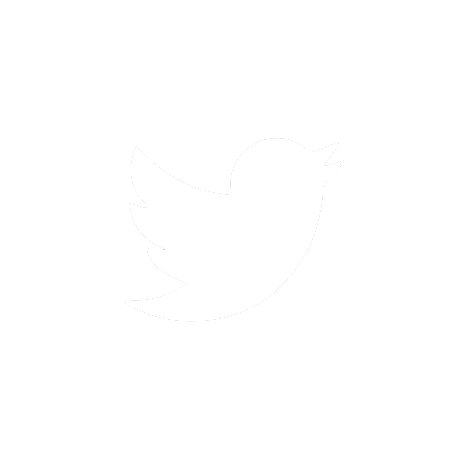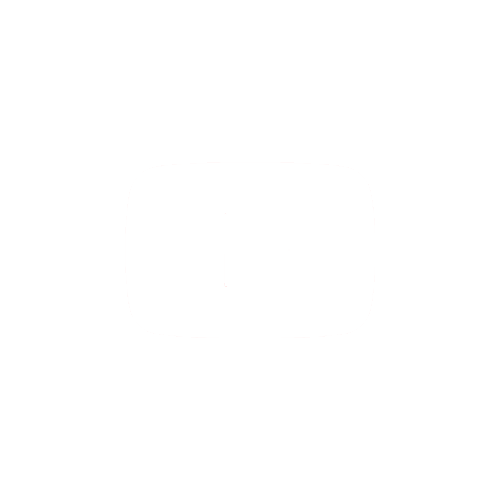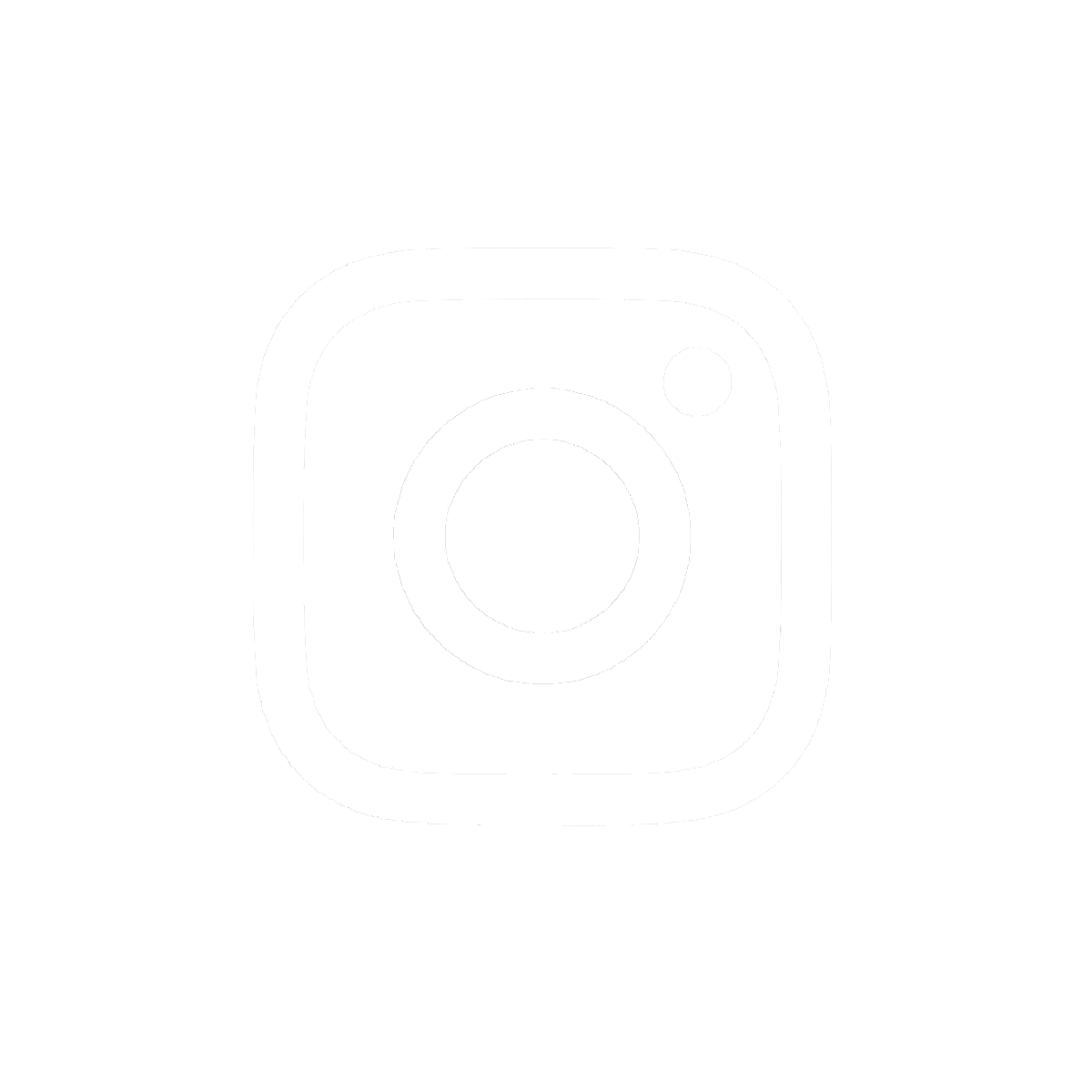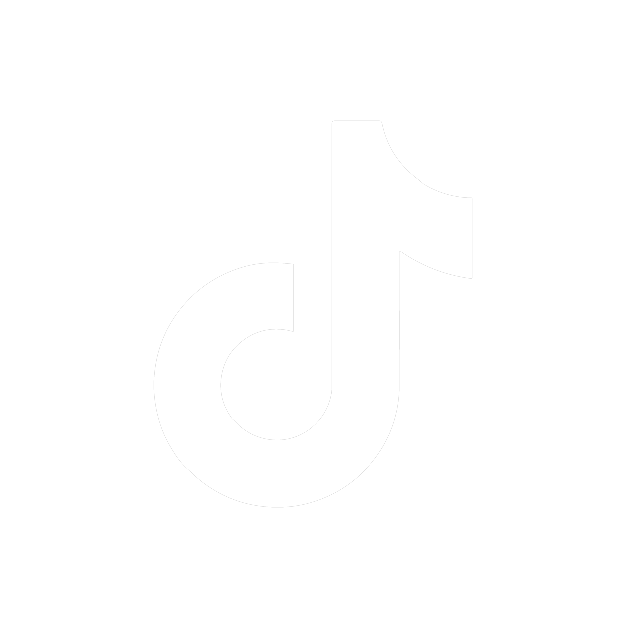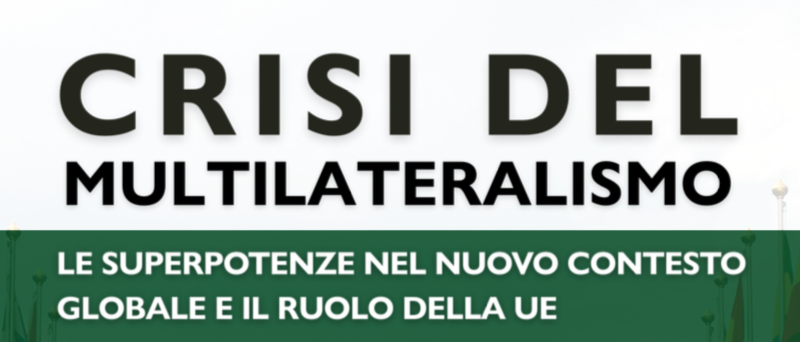Dall’inizio del 2025 sono 11 le vittime di femminicidio.
Due giovani donne uccise a distanza di meno di ventiquattro ore, Ilaria Sula e Sara Campanella. Lo stesso sgomento accoglie questa notizia, lo stesso dolore e la stessa rabbia.
Non ci possiamo accontentare delle analisi banalizzanti e semplicistiche, degli appelli securitari che non ne riconoscono la complessità e tanto meno l’origine.
La violenza sulle donne è strutturale e culturale in una società patriarcale, quale è la nostra, e la mancata condivisione delle cause profonde del fenomeno ne impedisce lo sradicamento.
Immaturità sentimentale e affettiva
Da più parti si sta facendo spazio un’analisi che ne mette in luce aspetti nuovi. Alla maggiore consapevolezza, all’indipendenza e all’empowerment delle donne non corrisponde una adeguata evoluzione della maturità sentimentale e affettiva degli uomini, spesso giovani, che si mostrano impreparati alla gestione della frustrazione derivante dal diniego subito, incapaci di riconoscere l’altra da sé, la sua volontà, persino la sua esistenza, tanto da arrivare a porne la fine senza poi saperne motivare la ragione.
Ai progressi ottenuti nella parità di genere da parte delle donne, dal secondo dopoguerra a oggi, si contrappone, non solo la ben nota parte refrattaria al cambiamento, ma anche una nuova, che reagisce in modo violento e che sta riempiendo il vuoto educativo del maschio nella società contemporanea. La misoginia cresce, dilaga in rete e sui social network, questi diventano luogo di aggregazione, radicalizzazione e diffusione dell’odio di genere. Basta mettere il naso fuori dalla propria bolla per rendersene conto.
Stato e istituzioni
Lo Stato e le istituzioni tutte devono operare su più fronti per attuare quella rivoluzione culturale necessaria al cambiamento, devono adottare ogni strumento necessario e utile alla prevenzione, alla tutela delle donne sottoposte a violenza e che vedano minacciata la propria sicurezza.
Non ci bastano le lacrime post mortem dei rappresentanti politici, i proclami inutili. Dell’interessamento intermittente alla questione o di proposte ridicole, non sappiamo che farcene.
Quello che chiediamo:
- Introduzione dell’educazione affettiva in tutti i livelli di istruzione a partire dalla scuola dell’infanzia;
- Accesso universale del Sistema sanitario nazionale alla psicoterapia e programmi di familiarizzazione universale;
- Programmi trasversali di educazione e sensibilizzazione alla parità di genere e alla cultura del consenso e un adeguamento della nostra legislazione al principio del consenso, così come previsto dall’articolo 36 della Convenzione di Istanbul, ratificata dal nostro paese nel 2014 (vedi la campagna “Il sesso senza consenso è stupro” di Amnesty International Italia);
- Rafforzamento del sistema di intervento a difesa delle donne vittime di violenza, il potenziamento delle strutture tradizionali e la creazione di nuove, come la presenza di figure di riferimento nei luoghi di lavoro per la prevenzione della violenza di genere il supporto alle vittime.
I numeri
Femminicidi e violenza di genere
Nel 2024 sono 97 le vittime di femminicidio, gran parte delle quali uccise in ambito famigliare o affettivo, per mano del partner o dell’ex. A essi si aggiungono 1 caso di donna scomparsa e 7 casi in fase di accertamento. Sono 53 i tentati femminicidi riportati nelle cronache online di media nazionali e locali.
Dal 2019 al 2024 i reati riconoscibili come violenza di genere sono cresciuti di oltre il 25%, essi comprendono violenze sessuali e maltrattamenti, avvenuti in gran parte in ambito famigliare. Si registra inoltre un incremento del 5,7% per le violenze sessuali, del 4% per gli atti persecutori e dell’11% per i maltrattamenti.
Le violenze sessuali nel 2024 sono state 6.587, un trend in costante ascesa dal 2020 (con una lieve flessione solo nel 2023). Le vittime donne sono il 91%.
Per gli atti persecutori o stalking il 2024 raggiunge i valori massimi dal 2020, sia per i delitti commessi (20.289) che per le segnalazioni a carico degli autori (20.258). Tre su quattro delle vittime (il 75%) sono donne.
La percentuale di vittime di violenza che indica la casa come scenario della violenza rimane sostanzialmente invariata, attestandosi al 68%. Il 50% delle vittime indica il partner attuale come autore, il 21% l’ex partner, lo 0,8% un partner occasionale e l’11% un famigliare. Osservando nel complesso i dati nelle due annualità, nel 2024 crescono rispetto al 2023 gli ex partner (+47,1% gli ex-conviventi, +15,8% gli ex-partner, +44,2% gli amanti).
Violenza e abuso sul luogo di lavoro
Il rapporto “Non staremo al nostro posto. Per il diritto a un lavoro libero da molestie e violenze” realizzato da WeWorld insieme a Ipsos, relativo al 2024, rileva che il 60% dei lavoratori e delle lavoratrici intervistate ha dichiarato di essere a conoscenza di episodi di violenza avvenuti nel luogo di lavoro, il 71% di microaggressioni. Il 42% degli intervistati ha subito e/o assistito a episodi di violenza al lavoro, mentre il 22% ha subito violenza nel luogo di lavoro almeno una volta nella vita, dato che sale al 28% per le donne. Si tratta soprattutto di violenza verbale, mobbing, abuso di potere. Le denunce sono pochissime, più di 6 donne su 10 non lo fanno per paura di ritorsioni.
L’86,4% dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia afferma che sul luogo di lavoro non c’è una persona a cui rivolgersi per segnalare o avere supporto in caso di molestie.
2,7 milioni di donne hanno subito
Sono circa 2,68 milioni le donne italiane tra i 15 e i 70 anni che hanno subito una qualche forma di molestia o un ricatto di natura sessuale, come la richiesta di prestazioni sessuali, per ottenere un lavoro e/o un avanzamento di carriera; nel 96% dei casi, l’autore di questi ricatti è un uomo.
Gli autori delle violenze sono in prevalenza capi e colleghi uomini. Una donna su 2 tra quelle che hanno subito violenza sul luogo di lavoro ha indicato il proprio capo, un uomo, come autore della violenza.
Nel 2024, Istat ha pubblicato un’indagine sulle molestie subite nel contesto lavorativo, analizzando un campione di età compresa tra i 14 e i 70 anni. Si stima che tra il 2022 e il 2023 siano 2,322 milioni le persone in Italia che hanno subito nel corso della vita almeno una molestia sul lavoro, fisica, psicologica o sessuale. Di queste, l’81,6% sono donne.
Violenza e odio di genere in rete
Dalla risultanza del monitoraggio su hate speech in rete, le donne appaiono la categoria più bersagliata: si eccede di quasi sette punti dal 2022 ad oggi dal 43,21% al 50%.
Fonti: ISTAT, Osservatorio Diritti, Non una di meno, WeWorld, Amnesty International Italia.
Volete essere informati delle azioni di DiEM25? Registratevi qui!